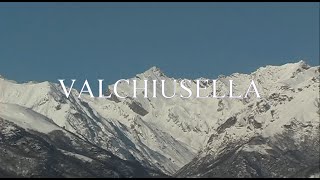Descrizione
Collocato nel cortile della Biblioteca a lui intitolata, il modello della "Sfera Metidrica" del Vignot testimonia della sua fervida immaginazione e delle sue doti di inventore.
È nel 1878 che negli scritti del Vignot compare per la prima volta il termine “Metidrica”, un riferimento al suo sogno di inventore, il progetto a cui dedicherà gran parte della sua vita; lui, nato in mezzo ai monti, ossessionato dal desiderio di esplorare le profondità del mare.
Il progetto della Sfera “Metidrica”, neologismo coniato utilizzando due vocaboli in lingua greca: “Metá” (assieme a) e “Hydor” (acqua), quindi “Methydor”, letteralmente “assieme all’acqua”, riguarda la realizzazione di quello che possiamo considerare a buon titolo un antesignano del moderno batiscafo. Il concetto alla base del progetto della Sfera Metidrica si discostava assolutamente da quello dei sommergibili all'epoca funzionanti; questi erano infatti concepiti per la navigazione sottomarina ed il loro affondamento avveniva sia mediante zavorra che mediante eliche. La Sfera Metidrica, con un peso di circa 5 tonnellate e un diametro di 5 metri, doveva invece solo scendere in profondità e non era progettata per effettuare spostamenti in orizzontale.
Anche il principio di affondamento ed emersione era totalmente diverso; una sfera di cinque metri di diametro con una doppia parete perimetrale spessa circa dieci centimetri tra corazzatura esterna ed interna. Fra le due corazzature vi era un'intercapedine di tavole di legno dello spessore di due centimetri caduna. Queste erano disposte ortogonalmente le une sulle altre, formando così una sorta di compensato molto robusto. Erano, inoltre, ben calafatate e catramate in modo che la struttura fosse perfettamente impermeabile. All'interno e un po' al disotto dell'equatore della sfera, era disposta un'intercapedine strutturata allo stesso modo dell'involucro esterno.
Questo serviva a separare in modo ermetico la calotta superiore da quella inferiore. Al di sotto di questo soppalco erano disposti, uno sopra all'altro, due tubi in ghisa molto resistenti, avvolti in forma torica; erano i serbatoi dell'aria compressa: quello superiore di diametro maggiore per l'alta pressione, quello inferiore per l'aria di respirazione. Due tubi attraversavano la sfera dalla parte inferiore esterna alla parte superiore esterna ed erano paralleli tra di loro; erano i tubi di guida, ed attraverso due spie si poteva controllare la velocità di discesa e di risalita della sfera. Sul piano divisorio, nella parte superiore, sboccavano altri due tubi che attraversavano la calotta inferiore e fuoriuscivano nella parte inferiore esterna della sfera stessa; questi erano le narici che erano utilizzate per far affluire l'acqua nella calotta superiore zavorrando così la sfera, che appesantita, si immergeva. L'acqua affluiva nella calotta superiore quando attraverso due tubi soffiatori veniva aspirata l'aria. Per la manovra inversa, la risalita, l'acqua veniva ricacciata quando i tubi soffiatori rimettevano aria nella calotta superiore. Al fondo della sfera vi era un pozzetto abbastanza ampio che era utilizzato per esplorare il fondo marino che poteva altresì essere osservato anche attraverso gli oblò predisposti lateralmente sull'involucro della sfera stessa.
Costruita sotto la guida del Corzetto presso lo stabilimento navale "Vitaliani Conte e C." di Spezia. la sfera fu trasportata su un possente carro dell'esercito in San Bartolomeo e posta sulla spiaggia. Venne messa in acqua il 29 Giugno del 1895.
Proprio in San Bartolomeo furono effettuate le prime sei immersioni sperimentali; dopo l'ultima di queste, una notte, la sfera metidrica affondò autonomamente. Era stata dimenticata qualche valvola aperta? Era stata fatta affondare volutamente da mano ignota per dispetto o per sabotaggio? Nessuno saprà dare una risposta a queste domande. Corzetto fece rimorchiare a questo punto la Sfera nel Golfo di Lerici, presso il quale proseguirono le immersioni, che procedettero senza intoppi fino alla dodicesima. La tredicesima per poco non fu fatale; una perdita di aria dal serbatoio ad alta pressione non consentì la risalita: mancava l'aria per ricacciare l'acqua dalla calotta superiore. L'equipaggio formato da quattro persone, ivi compreso il Vignot, rimase prigioniero sul fondo del mare per ben diciotto ore. L'intervento di un pontone della Marina Militare, al comando dell'ammiraglio Camillo Candiani, provvide a riportare la Sfera in superficie, salvando così i quattro uomini.
La disavventura non scoraggiò Pietro, che dopo un mese riprese i suoi esperimenti; le operazioni richiamavano sempre grandi folle di spettatori (anche Mantegazza e Marconi furono a più riprese testimoni di tali momenti). Dopo un primo brevetto ottenuto nel 1893, Corzetto ne consegue un secondo nel 1897 (apportando alcune modifiche migliorative al progetto).
Nel 1899, un imprenditore per recuperi di navi sommerse, un certo Fabiani, contattò Pietro per incaricarlo del recupero di una imbarcazione affondata durante un fortunale: sembrava finalmente l’ occasione per dimostrare l'utilità dell'invenzione. Pietro affrontò ingenti spese per attrezzarsi adeguatamente: costruì un certo numero di serbatoi metidrici che dovevano affiancare la Sfera per il recupero del vapore ed altre attrezzature ausiliarie. Purtroppo a un certo punto, lamentando ritardi nonostante il contratto non prevedesse termini di scadenza, ritirò l’incarico; la causa di fallimento che ne seguì, dalla quale Pietro ottenne il proscioglimento da ogni addebito, durò però quasi tre anni, periordo di tempo entro il quale tutti gli averi del nostro rimasero sotto sequestro.
Dopo questi fatti si ha notizia della Sfera semisommersa fra la Palmaria e Portovenere. In una relazione del comando dei Carabinieri del luogo, compare per la prima volta il nome che era stato imposto alla Sfera Metidrica: "VITALIA". Non sono stati rinvenuti documenti che attestino la sua demolizione.
A parziale (e postumo) risarcimento di queste difficili vicende, il progetto del Vignot sarà poi studiato e ri-elaborato da diversi uomini di scienza, che la Sfera Metidrica può essere oggi considerata a buon diritto, come già accennato, l’antesignana dei moderni batiscafi.
Il progetto della Sfera “Metidrica”, neologismo coniato utilizzando due vocaboli in lingua greca: “Metá” (assieme a) e “Hydor” (acqua), quindi “Methydor”, letteralmente “assieme all’acqua”, riguarda la realizzazione di quello che possiamo considerare a buon titolo un antesignano del moderno batiscafo. Il concetto alla base del progetto della Sfera Metidrica si discostava assolutamente da quello dei sommergibili all'epoca funzionanti; questi erano infatti concepiti per la navigazione sottomarina ed il loro affondamento avveniva sia mediante zavorra che mediante eliche. La Sfera Metidrica, con un peso di circa 5 tonnellate e un diametro di 5 metri, doveva invece solo scendere in profondità e non era progettata per effettuare spostamenti in orizzontale.
Anche il principio di affondamento ed emersione era totalmente diverso; una sfera di cinque metri di diametro con una doppia parete perimetrale spessa circa dieci centimetri tra corazzatura esterna ed interna. Fra le due corazzature vi era un'intercapedine di tavole di legno dello spessore di due centimetri caduna. Queste erano disposte ortogonalmente le une sulle altre, formando così una sorta di compensato molto robusto. Erano, inoltre, ben calafatate e catramate in modo che la struttura fosse perfettamente impermeabile. All'interno e un po' al disotto dell'equatore della sfera, era disposta un'intercapedine strutturata allo stesso modo dell'involucro esterno.
Questo serviva a separare in modo ermetico la calotta superiore da quella inferiore. Al di sotto di questo soppalco erano disposti, uno sopra all'altro, due tubi in ghisa molto resistenti, avvolti in forma torica; erano i serbatoi dell'aria compressa: quello superiore di diametro maggiore per l'alta pressione, quello inferiore per l'aria di respirazione. Due tubi attraversavano la sfera dalla parte inferiore esterna alla parte superiore esterna ed erano paralleli tra di loro; erano i tubi di guida, ed attraverso due spie si poteva controllare la velocità di discesa e di risalita della sfera. Sul piano divisorio, nella parte superiore, sboccavano altri due tubi che attraversavano la calotta inferiore e fuoriuscivano nella parte inferiore esterna della sfera stessa; questi erano le narici che erano utilizzate per far affluire l'acqua nella calotta superiore zavorrando così la sfera, che appesantita, si immergeva. L'acqua affluiva nella calotta superiore quando attraverso due tubi soffiatori veniva aspirata l'aria. Per la manovra inversa, la risalita, l'acqua veniva ricacciata quando i tubi soffiatori rimettevano aria nella calotta superiore. Al fondo della sfera vi era un pozzetto abbastanza ampio che era utilizzato per esplorare il fondo marino che poteva altresì essere osservato anche attraverso gli oblò predisposti lateralmente sull'involucro della sfera stessa.
Costruita sotto la guida del Corzetto presso lo stabilimento navale "Vitaliani Conte e C." di Spezia. la sfera fu trasportata su un possente carro dell'esercito in San Bartolomeo e posta sulla spiaggia. Venne messa in acqua il 29 Giugno del 1895.
Proprio in San Bartolomeo furono effettuate le prime sei immersioni sperimentali; dopo l'ultima di queste, una notte, la sfera metidrica affondò autonomamente. Era stata dimenticata qualche valvola aperta? Era stata fatta affondare volutamente da mano ignota per dispetto o per sabotaggio? Nessuno saprà dare una risposta a queste domande. Corzetto fece rimorchiare a questo punto la Sfera nel Golfo di Lerici, presso il quale proseguirono le immersioni, che procedettero senza intoppi fino alla dodicesima. La tredicesima per poco non fu fatale; una perdita di aria dal serbatoio ad alta pressione non consentì la risalita: mancava l'aria per ricacciare l'acqua dalla calotta superiore. L'equipaggio formato da quattro persone, ivi compreso il Vignot, rimase prigioniero sul fondo del mare per ben diciotto ore. L'intervento di un pontone della Marina Militare, al comando dell'ammiraglio Camillo Candiani, provvide a riportare la Sfera in superficie, salvando così i quattro uomini.
La disavventura non scoraggiò Pietro, che dopo un mese riprese i suoi esperimenti; le operazioni richiamavano sempre grandi folle di spettatori (anche Mantegazza e Marconi furono a più riprese testimoni di tali momenti). Dopo un primo brevetto ottenuto nel 1893, Corzetto ne consegue un secondo nel 1897 (apportando alcune modifiche migliorative al progetto).
Nel 1899, un imprenditore per recuperi di navi sommerse, un certo Fabiani, contattò Pietro per incaricarlo del recupero di una imbarcazione affondata durante un fortunale: sembrava finalmente l’ occasione per dimostrare l'utilità dell'invenzione. Pietro affrontò ingenti spese per attrezzarsi adeguatamente: costruì un certo numero di serbatoi metidrici che dovevano affiancare la Sfera per il recupero del vapore ed altre attrezzature ausiliarie. Purtroppo a un certo punto, lamentando ritardi nonostante il contratto non prevedesse termini di scadenza, ritirò l’incarico; la causa di fallimento che ne seguì, dalla quale Pietro ottenne il proscioglimento da ogni addebito, durò però quasi tre anni, periordo di tempo entro il quale tutti gli averi del nostro rimasero sotto sequestro.
Dopo questi fatti si ha notizia della Sfera semisommersa fra la Palmaria e Portovenere. In una relazione del comando dei Carabinieri del luogo, compare per la prima volta il nome che era stato imposto alla Sfera Metidrica: "VITALIA". Non sono stati rinvenuti documenti che attestino la sua demolizione.
A parziale (e postumo) risarcimento di queste difficili vicende, il progetto del Vignot sarà poi studiato e ri-elaborato da diversi uomini di scienza, che la Sfera Metidrica può essere oggi considerata a buon diritto, come già accennato, l’antesignana dei moderni batiscafi.
La mostra "UN POETA IN FONDO AL MARE", curata da Fulvio Bortolozzo (sulla base delle ricerche condotte da Domenico Camosso e Dilma Formento) e realizzata nel 1998 con il patrocinio del Comune di Rueglio e della Regione Piemonte, rappresenta un valido strumento per approfondire il pensiero e l'opera del poeta-scienziato, per offrire alle generazioni attuali e future quella memoria storica.
Quello ospitato nel cortile della Biblioteca è il modello in scala della Sfera Metidrica realizzato in concomitanza della mostra.
Indirizzo e punti di contatto
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Via San Gottardo, 2 (presso il cortile della Biblioteca Comunale "Pietro Corzetto Vignot") |
Mappa
Indirizzo: Via Enrico Compagno, 5, 10010 Rueglio TO, Italia
Coordinate: 45°28'7,4''N 7°45'20,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Galleria fotografica
Galleria video
Numero video: 8
Modalità di accesso
accessibile tramite cortile della biblioteca posto al piano strada. Non sono previsti costi di accesso.